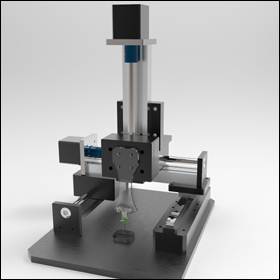- In:
- Posted By: Redazione
- Commenti: 0
I cambiamenti climatici minacciano produzione del mais

Siccità e ondate di calore nel periodo estivo saranno, da qui al 2050, responsabili della diminuzione di produzione a scala europea del mais.
Per il frumento, che presenta un ciclo colturale più precoce, si prevedono invece aumenti di resa. A individuare nuovi modelli di pratiche colturali e di miglioramento genetico delle varietà erbacee per contrastare gli effetti del riscaldamento globale, un team di ricercatori internazionali di cui fanno parte Istituto di biometeorologia Cnr e Università di Firenze. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature Communications
L’agricoltura è fra i settori produttivi maggiormente esposti alla variabilità climatica. Stress idrico e termico potrebbero essere causa di una riduzione, da qui al 2050, della produzione, su scala europea, di mais. Per contrastare questi effetti, anche in considerazione dei nuovi dati del Rapporto Speciale “Global warming of 1.5°C” - IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change sul superamento del limite di 1,5 gradi del riscaldamento globale nel 2040), un team internazionale di cui fanno parte ricercatori dell’Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibimet) e del Dipartimento di scienze delle produzioni agroalimentari e dell’ambiente (Dispaa) dell’Università di Firenze, ha individuato nuovi modelli di pratiche colturali e di miglioramento genetico delle varietà di mais e frumento. I risultati della ricerca, realizzata all’interno del progetto europeo MACSUR (Modeling European Agriculture with Climate Change for food Security), sono stati pubblicati su Nature Communications.
“Sono stati analizzati”, spiega Marco Moriondo, ricercatore Cnr-Ibimet, “i possibili effetti del cambiamento climatico sulle rese di frumento e mais a livello europeo, utilizzando dieci modelli colturali diversi e valutando, regione per regione, i principali determinanti dei rischi per le produzioni agricole fino al 2050”. Uno studio di questo tipo rappresenta una solida base su cui costruire risposte adattative coerenti con i previsti cambiamenti climatici per mantenere buoni livelli produttivi in agricoltura.