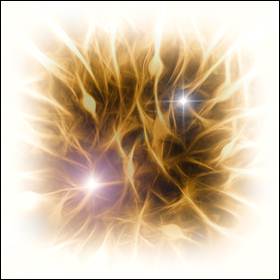- In:
- Posted By: Redazione
- Commenti: 0
Olfatto e patologie neurodegenerative

L'olfatto ci fa percepire gli stimoli odorosi e ci consente di relazionarci con il mondo che ci circonda.
Se non esistesse, la nostra vita sarebbe molto diversa. È un senso fondamentale per gli esseri umani, anche se spesso non ci rendiamo della sua importanza. L'olfatto, oltre a farci percepire gli stimoli odorosi e a consentirci di relazionarci con il mondo che ci circonda, ha infatti impatto sulle relazioni umane. “Fino agli anni '70, questo senso era considerato poco importante poiché nelle varie fasi dell'evoluzione dell'uomo la sua funzione si è ridotta, diversamente da quanto accaduto negli animali”, spiega Alessandro Tonacci, ricercatore dell'Istituto di fisologia clinica (Ifc) del Cnr di Pisa.
A spingerci a sottovalutarne l'importanza è anche il fatto che la perdita della funzione olfattiva ha impatto minore sulla qualità della vita rispetto a quella di altri sensi, come ad esempio la vista.
“Intorno agli anni '70 studi condotti negli Stati Uniti hanno invece dimostrato che esiste una correlazione tra la perdita o la diminuzione dell'olfatto e patologie neurodegenerative, in primis – ma non solo – Alzheimer e Parkinson”, spiega il ricercatore. “Ciò avviene in quanto alcune delle aree corticali nelle quali si verificano i primi episodi di morte cellulare dovuta a queste patologie sono coinvolte anche nel processing del segnale olfattivo rendendo, di fatto, la valutazione olfattiva un utile biomarcatore precoce di insorgenza della patologia. Nel tempo c'è stata quindi una sua rivalutazione e molte sono state le ricerche scientifiche in questo ambito, tanto che nel 2004 il Nobel per la Medicina è stato assegnato agli americani Richard Axel e Linda Buck per le loro ricerche sui recettori olfattivi e sul funzionamento del sistema olfattivo, che hanno permesso di spiegare i meccanismi che permettono di percepire 10.000 odori diversi e di collegarli alla memoria umana insieme alle emozioni che il nostro cervello lega a essi”.